Self care
FIGHTING FOR SELF CARE! PRENDERSI (RADICALMENTE) CURA DI SE’
10 Maggio 2022
“Caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation, and that is an act of political warfare.”
― Audre Lorde
Durante una conferenza internazionale, ho avuto la fortuna di poter ascoltare Jessica Ayden Li, attivista per la giustizia sociale, parlare di self care radicale, che definisce così
La cura radicale di sé ha a che fare con il creare uno spazio e dare a noi stesse/i l’approvazione per staccarci dalle credenze tradizionali di mettere sempre gli altri prima di noi stesse/i. Si tratta di prendere un impegno personale ogni giorno per prendersi cura di noi stesse/i in modo olistico. Abbiamo bisogno di misurarci con noi stesse/i prima di poterci prendere cura di chiunque altro.
Come ho scritto in “self che?”, confondiamo spesso – perché subiamo un condizionamento sociale e culturale – la cura di sé con la creazione di abitudini che riguardano solo in parte e solo per un tempo ristretto il nostro benessere e quello del mondo che ci circonda, senza contemplare che la cura di sé ha a che fare con un diritto fondamentale universale.
I media contribuiscono a divulgare quell’idea di cura di sé e tempo per sé che distorce completamente il suo reale significato, fino ad influenzare una e vera e propria ossessione per il raggiungimento di risultati che nulla hanno a che fare con la nostra scelta, con il nostro profondo sentire. Senza neanche chiederci se ciò che ci viene quotidianamente sottoposto come salvifico per la nostra salute sia ciò di cui sentiamo il bisogno, ci omologhiamo per non dover subire il giudizio di una società che giudica esclusivamente in relazione alle nostre performance.
La vita diventa una performance continua, e non c’è nulla di più estraneo al concetto di cura di sè.
Dopo l’ennesimo spiegone di una persona che durante una cena ci illustrava ogni suo programma di allenamento per mantenere la forma giusta e che sentenziava che “basta fare sport ogni sera dopo il lavoro per perdere peso, è una questione di forza di volontà!”, impartendo consigli assolutamente non richiesti ai presenti su come sviluppare la passione per lo sport, mio marito tornando a casa mi chiese “ma io ho mai detto a lui che per stare bene dovrebbe imparare a suonare uno strumento o dedicarsi alla lettura dopo il lavoro? No, perchè credo che non abbia neanche un libro in casa: è evidente che non ama leggere, ed a me non interessa dare lezioni su quanto sia importante dedicare del tempo alla conoscenza ad una persona che la considera del tutto secondaria nella vita. E dire che un pò di amore per la conoscenza lo renderebbe più umile, ma non è un mio problema”. Fino a quel momento non avevo riflettuto su quanto fossi circondata da questa visione del benessere, da quanto “no pain no gain” style vi fosse nei ragionamenti di alcune persone. Siamo abituate/i a valutare se una persona si prenda meno cura di sè attraverso il suo aspetto esteriore, attraverso la performance fisica. Certamente vi capiterà migliaia di volte di sentir dire “hai visto come sta bene Tizia? E’ dimagrita, si vede che ora ci tiene…prima era troppo in carne, è triste vedere donne che non si curano della propria forma, come pretendono poi di trovare qualcuno che sia interessato a loro?”: Tizia, che ora ci tiene alla sua salute, ha iniziato a praticare digiuni incontrollati seguendo le istruzioni di una app, ha eliminato ogni fonte di carboidrati dalla dieta perchè convinta che siano nemici della vita, mangia solo verdura, ed ha iniziato a sgranocchiare barrette simili alle palle di semi che si lasciano in inverno per gli uccelli fuori dal balcone, se non fa la cacca per un giorno va in ansia da sovrappeso e non passa un giorno senza salire sulla bilancia. Parla sempre del suo peso, di quanto sia ingrassata, delle tette troppo piccole o troppo grandi, delle smagliature e della cellulite che non riesce ad eliminare, della pancia gonfia e della rughetta a lato della bocca. Trascorre ore al trucco e spende un patrimonio in prodotti di make up, ogni mattina tira fuori tutto quello che ha nell’armadio e non riesce a sentirsi a suo agio in nessuno degli abiti che indossa: troppo lunghi, troppo corti, troppo stretti, troppo larghi, troppo neri o troppo colorati. Non prova mai soddisfazione per il proprio corpo, neanche di fronte ad un complimento, perchè sin da bambina chiunque in famiglia le faceva notare ogni sua caratteristica come un difetto: appariscente, goffa, cicciottella o scheletrica, con i fianchi troppo grandi, il seno troppo piccolo o troppo grande, troppo bassa o troppo alta, troppo silenziosa o logorroica. E le spiegavano anche che tutte queste cose le dicevano per il suo bene, nessun altro lo avrebbe fatto con tanta sincerità, perchè il mondo fuori è pieno di gente falsa, che critica alle spalle i tuoi “difetti”. E quindi, come potrebbe Tizia prendere un complimento per buono? Come potrebbe non ritenere che la cura di sé passi esclusivamente per il raggiungimento di obiettivi socialmente approvati ed omologati, tanto da potersi servire di un app? La cura di sé passa anche per la cura del proprio corpo, ma ognuno/a di noi vive la propria fisicità in maniera diversa, in relazione alla propria condizione mentale, alle proprie esperienze di vita, alle proprie scelte: come possono un’app, o il /la fitness influencer, sostituire coloro che hanno investito le proprie vite per acquisire specifiche competenze in campo nutrizionale, nel campo dell’educazione fisica, della psicoterapia ecc?
Ma capita anche di sentire “finalmente Caio ha deciso di mettersi in forma e prendersi cura di sé, ha iniziato ad andare in palestra ed ha un personal trainer che lo segue, visto che fisico?”. Caio, nel giro di pochi mesi, avrà il busto di Big Jim e le zampe di un merlo, non uscirà più con gli amici per una birra o una cena perchè segue una dieta molto rigida e strutturata che non può tradire, non farà che parlare di massa magra e massa grassa mentre mantiene la postura da body builder in gara anche mentre solleva la tazzina del caffè senza zucchero. Giudicherà ogni corpo che incontra per strada, dicendo che se non fai sacrifici non puoi lamentarti della pancetta – perchè immagina che chiunque lo veda ambisca a diventare come lui – e che le donne di certo amano quelli con il suo fisico, perchè ovviamente è l’esteriorità che sancisce il valore di una persona, e la tenacia con cui si è raggiunto quel primario – direi primitivo – e umanamente indispensabile obiettivo. La massima rappresentazione dell’individualismo, che mette in campo ogni possibile sacrificio unicamente per scolpire la propria immagine esteriore. Fanculo il resto. Caio diventerà una delle tante persone affette da bigoressia o vigoressia.
Mi capita così spesso di vedere foto di persone che si allenano, mostrano i muscoli, informano la popolazione su quante calorie hanno bruciato e cosa non hanno mangiato, di come non si possa pretendere di vivere felicemente senza scolpire i propri muscoli, che a volte vorrei postare la foto della mia cacca al mattino: è una cosa che mi rende felice perchè non sono molto regolare, mi fa iniziare bene la giornata, sta ad indicare che sto bene…perchè non dovrei dirlo al mondo, in fondo non possiamo pretendere di vivere felici senza fare la cacca!
Con tutto ciò non sto sentenziando certamente che chiunque abbia a cuore la cura del proprio corpo anche attraverso l’attività fisica o la dedizione ad una disciplina sia come i vari Tizia e Caio, io stessa ho praticato dell’agonismo, frequentato palestre, incontrato istruttrici ed istruttori competenti – e non personal trainer improvvisati solo perchè appunto sembrano Big Jim o hanno un bell’aspetto – mi piace trascorrere del tempo nelle mani di una estetista e molte altre cose.
Ciò su cui rifletto e vi invito a riflettere, è quanto sia diffusa l’inclinazione a sviluppare vere e proprie ossessioni per l’aspetto esteriore e la performance che non hanno nulla a che fare con il concetto di benessere: la lista dei disturbi è piuttosto lunga, e va al di là di quelli che un tempo erano i più comuni disturbi alimentari.
Sopra ho menzionato la bigoressia, che principalmente riguarda gli uomini anche se molte donne ne sono colpite. C’è anche l’ortoressia, ovvero l’ossessione per i cibi sani che, oltre a provocare squilibrio a livello sociale ed individuale, comporta anche gravi carenze conseguenti l’adozione di diete sbilanciate.
Si è ormai normalizzata la tendenza a non considerare l’individuo come entità complessa, che non può spegnere e accendere soltanto alcune perti di sé e tralasciare tutto il resto. Non è vero che se il corpo sta bene, di conseguenza anche la mente sarà sana, nè viceversa. Non è vero che “siamo ciò che mangiamo”, ma siamo anche il nostro patrimonio genetico, le nostre esperienze, i nostri sentimenti. Nulla di tutto ciò può essere omologato, per definizione. Non siamo automobili, che escono dalla fabbrica tutte uguali e con le stesse caratteristiche e prestazioni. Il graffio dell’auto appena prodotta è un difetto di fabbrica, ma una cicatrice, la struttura corporea, la ruga, la grandezza del seno, la scelta dei cibi, sono semplicemente delle caratteristiche individuali, nè pregi nè difetti.
Tizia e Caio potrebbero avere dei figli, ed è questo ciò che mi preoccupa sul piano evolutivo.
In questa società ci viviamo tutt*, e nessun* è esente dall’esposizione continua a questo concetto di cura di sé, non è una vergogna ammettere di esserne in parte influenzate/i e scegliere di seguire alcune tendenze, il problema nasce quando perdiamo consapevolezza che tutto ciò non ha a che fare con il benessere, ovvero con uno stato di equilibrio momentaneo e dinamico dal punto di vista biologico, psichico e sociale, come definito dall’OMS. Il problema diventa un guaio ben più grande quando portiamo questa assenza di consapevolezza all’interno delle nostre relazioni familiari, amicali, lavorative.
Non vi è nulla di più rivoluzionario e femminista della cura di sé
perché rappresenta una scelta politica in un mondo ostile, che tenta di omologare pensieri e comportamenti, che abbatte ogni giorno la nostra capacità di autodeterminarci. L’autodeterminazione delle donne sta sul culo al mondo, e non va bene se scegliamo anche come stare bene. La cura di sé ha a che fare con quella rivoluzione che necessariamente ognuna di noi mette in campo nella propria vita, scegliendo di non seguire i dettami di un sistema che prima di tutto ci vuole come caregivers, eternamente impegnate nella cura del prossimo, in quella precisa divisione di ruoli che piace tanto, ahinoi, ad un sacco di gente non per forza nata nel secolo scorso.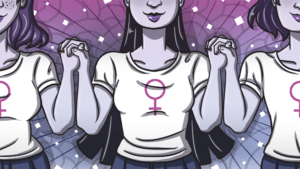 La cura di sé è potere, un potere di cui ci riappropriamo nel momento in cui mettiamo al centro noi stesse, i nostri vissuti, la nostra salute, le nostre relazioni, la nostra sessualità, e decidiamo delle nostre vite. E’ il potere di dire “no”, di mettere al centro la nostra salute mentale e fisica e di costruire il tempo da dedicare a noi stesse come una necessità.
La cura di sé è potere, un potere di cui ci riappropriamo nel momento in cui mettiamo al centro noi stesse, i nostri vissuti, la nostra salute, le nostre relazioni, la nostra sessualità, e decidiamo delle nostre vite. E’ il potere di dire “no”, di mettere al centro la nostra salute mentale e fisica e di costruire il tempo da dedicare a noi stesse come una necessità.
Come attiviste femministe, ci troviamo ad affrontare diversi piani della cura di sé. Scegliere di essere attiviste è un impegno che necessariamente coinvolge la nostra sfera privata, le scelte di vita e la visione del mondo, ma a volte troviamo difficoltà a separare l’impegno collettivo da quello individuale. Come se non potessimo permetterci di scegliere. E ci troviamo in situazioni di vita quotidiana che ci mettono a disagio. Un esempio su tutti è la conversazione con un parente che fa battute sessiste o afferma che esiste una distinzione di ruoli nella società. Riconosco che è stressante – anche se per me queste situazioni fungono da ispirazione per la maggior parte delle cose che scrivo! – e che lo è ancor di più prendere una posizione che verrebbe squalificata come “la solita femminista”, come se a parlare fosse una persona priva di qualsiasi competenza e, ancor peggio, non possa permettersi di intervenire su ragionamenti che riguardano la propria vita, le discriminazioni subite, a causa di una storia in cui il potere lo avevano proprio persone come il parente in questione. A volte, prendersi cura di sé vuol dire rinunciare a queste discussioni informali che non hanno nulla di costruttivo, se non creare tensioni con persone della nostra cerchia affettiva. Altre volte può farci sentire meglio invece controbattere anche solo per mostrare la mediocrità di tali ragionamenti. Ma dobbiamo scegliere noi quale parte del nostro stare al mondo vogliamo mettere in campo in queste circostante. Questo ha a che fare con la cura di sé: agire non per dover dimostrare qualcosa, ma per stare bene con sé in quel momento. Se siamo combattute perché vorremmo reagire per non mostrarci deboli, ma non vogliamo neanche sollevare grandi discussioni, c’è sempre il piano no verbale della comunicazione. Vale la pena leggere la Guida di autodifesa verbale per femministe!
Può accadere anche in una discussione pubblica, attraverso i social o di persona: quante volte ci sentiamo dire “Avresti dovuto controbattere” oppure “Era meglio non rispondere, hai dato troppa importanza a quella persona” e ancora “Non avresti dovuto rispondere a quel politico che cerca solo polemica”. A me è capitato anche di sentirmi dire “Sento che c’è rabbia nelle tue parole, dovresti essere indifferente”, parlando di una organizzazione che sistematicamente e ripetutamente sfrutta le persone che assume e le rende precarie. Siamo noi a decidere cosa sia meglio per noi, se parlare o tacere, e soprattutto non dovremmo mai farci dire quali emozioni provare, meno che mai che la rabbia sia una emozione negativa. Personalmente, rivendico la mia rabbia!
Un altro piano sul quale dovremmo fortemente impegnarci per rendere la cura di sé una vera e propria rivoluzione, è quello delle organizzazioni in cui siamo impegnate come attiviste e lavoratrici. La prima forma di manipolazione delle realtà in cui siamo impegnate, è proprio quella di non definirci “lavoratrici”: questo presta il fianco a quella stessa cultura patriarcale che ci vuole naturalmente predisposte al lavoro di accudimento e protezione, gratuito e non riconosciuto, privo di qualsiasi autorevolezza. Scrivo “presta il fianco” perché purtroppo questo approccio si è concretizzato proprio all’interno delle organizzazioni attraverso le quali accogliamo e supportiamo le donne che subiscono violenza. La ragione risiede certamente nel fatto che viviamo in un sistema oppressivo che non riconosce alle organizzazioni femministe le adeguate risorse per poter garantire le stesse opportunità di altri luoghi di lavoro. Questo fa parte della ormai consolidata strategia di abbattimento di luoghi e diritti delle donne attraverso la negazione di finanziamenti adeguati, non vi sono altre ragioni. Il salvadanaio non è vuoto, semplicemente non c’è, inutile girarci intorno. Le organizzazioni femministe sono autonome, o dovrebbero esserlo, hanno un approccio non neutrale, non scendono a compromessi sui diritti, e questo ovviamente non può essere tollerato in un mondo che vuole tenere sotto controllo ogni aspetto delle nostre vite, dai nostri corpi alle nostre relazioni. Ma quando siamo noi ad introiettare quella visione precaria del nostro lavoro, occorre rompere il vetro e schiacciare l’allarme, abbiamo più di un problema! Perché a combattere contro le istituzioni che ci negano ciò che è nostro, siamo abituate, ma non andremo mai più in là delle parole se a praticare quella stessa privazione siamo noi stesse contro di noi. Il lavoro è lavoro, e una attivista femminista svolge un lavoro competente all’interno della propria organizzazione, e può scegliere anche di fare del volontariato, che non coincide con il lavoro. Quando, per giustificare precarietà e salari da fame, facciamo appello all’attivismo ed all’impegno nella difesa di diritti umani che è stata la nostra scelta di vita, non facciamo altro che renderci complici del sistema che ci opprime, semplice.
Se non compiamo questa prima scelta come atto di ribellione, di certo non possiamo pensare al diritto di avere degli ambienti di lavoro sani, in cui il nostro benessere sia prioritario, in cui praticare quella radicale cura di sé di cui parla Jessica Ayden Li. Non facciamo altro che accettare il fatto che l’attenzione verso la cura di sé sia un lusso, quindi accettiamo la privazione di un diritto fondamentale.
Ci troviamo incastrate in una pesante contraddizione: mentre affianchiamo le donne nel percorso verso l’autodeterminazione, in nome della libertà individuale, viviamo la quotidianità di un sistema oppressivo che rende le nostre vite precarie. Sentiamo tutto il peso sulle nostre spalle: abbiamo scelto la strada che stiamo percorrendo, vogliamo cambiare questo mondo, vogliamo vivere una vita libere dalle oppressioni, ma per farlo è necessario scendere a compromessi con un sistema che ha come finalità quella di non farci neanche lontanamente raggiungere questi obiettivi.
I secoli ci hanno rese forti e consapevoli, fiere delle nostre battaglie, abili nello stare in movimento, ovvero nell’andare avanti con lo sguardo rivolto all’indietro quando necessario. La peggiore delle pandemie, il patriarcato, ha definito la nostra capacità di resistere attraverso la sorellanza, in ogni parte del mondo. Non possiamo permetterci di riprodurre nei nostri luoghi quella violenza che subiamo fuori: si, è questo che rischiamo di fare, se non ci occupiamo del nostro benessere. Come si può essere di aiuto a qualcun altro se prima di tutto non ci prendiamo cura di noi stesse, costrette a scegliere tra attivismo e vita privata e a mettere all’ultimo posto la nostra salute mentale e fisica? Come possiamo quotidianamente affrontare le storie di violenza di altre donne, che quindi riguardano anche noi, senza avere la possibilità di prevenire le conseguenze di tutto ciò?
Il minimo che possa accadere è che emergano tensioni e conflitti all’interno del contesto in cui ci troviamo, perché ognuna di noi porta con sé un carico emotivo che entra in collisione con quello delle altre, fino a provocare meccanismi di esclusione, burn out e mobbing. Violenza, insomma. Quindi violenze dentro e fuori, e noi a correre come il criceto sulla ruota per non dover lasciare sole le donne, per non rischiare di perdere quei finanziamenti che almeno fanno esistere i nostri luoghi, per non sentire di avere fallito, perché siamo attiviste, cazzo! E mentre corriamo sulla ruota, non abbiamo mica tempo di fermarci per guardarci in faccia e dirci che non va bene, che dobbiamo fare del tutto per salvarci e non rinunciare alla cura di noi stesse, che è la prima cosa da fare e la pià importante. Mentre corriamo sulla ruota, se per caso una di noi si ferma per chiedere “ehi, ma dove stiamo correndo? Fermiamoci, non lo vedete che ci stiamo logorando, che ci stiamo ammalando, che non ci guardiamo neanche più negli occhi? Fermatevi, rischiamo di farci del male!” le altre, intente a correre per il bene supremo e spinte da chi teme che la troppa cura di sé renda evidente le storture del sistema, rispondono “sei tu il problema! Non puoi pensare a te stessa, ci sono vite da salvare qui, non puoi fare come cazzo ti pare! Non lo vedi che non ci sono soldi? Come puoi essere così egoista, sei un’attivista o no? Non pensi alle donne e ai bambini? Togliti che dobbiamo correre, o non arriveremo mai a…a…vabbè…là!”. E dopo aver spintonato, insultato, e ridotto a brandelli chi ha osato dissentire, la lasciamo fuori dalla ruota, finché non riesce ad alzarsi per uscire dalla gabbia. Lo so, è un’immagine un po’ cruda, ma è ciò che accade più spesso di quanto pensiamo, all over the world. Meccanismi che si riproducono spesso senza che ce ne rendiamo conto, a volte perché manca la capacità di agire conflitti nascenti, altre perché scientificamente qualcuno sceglie di non agire quei conflitti fino a farli esplodere. Ma in questi casi, all’interno dell’organizzazione femminista, c’è stata una intrusione. E’ in questi casi che spesso si sceglie di allontanarsi, dopo aver tentato di schiacciare il tasto di allarme. Ma in tutti gli altri casi, abbiamo la possibilità di agire, di fermarci, e di scegliere. Abbiamo bisogno di stare in movimento, crescere, abbattere i muri e tenerci per mano, pianificare strategie che mettano al centro la cura di noi stesse, finché non sceglieremo con tutte le forze di farlo non potremo dire di aver tentato.
Non possiamo continuare a vivere nella contraddizione di dover rinunciare alla nostra autodeterminazione, alla nostra libertà di scelta, alla nostra indipendenza economica, per poter sostenere altre donne che arrivano nei centri antiviolenza, nelle case rifugio. Non possiamo continuare a dire che il personale è politico mentre il sostegno che diamo alle donne è in contrasto con la nostra vita privata, che ci vede, per poter garantire quel sostegno, dipendenti da mariti, padri, famiglie. Non possiamo seriamente pensare che essere un’attivista femminista implichi l’accettazione dello sfruttamento e la solitudine nell’affrontare l’impatto emotivo che le storie di donne e bambini hanno sulle nostre vite. Non possiamo convintamente asserire che il benessere viene prima per alcune donne e poi per altre. Non possiamo continuare a mettere a tacere il dissenso, nella speranza che nessuno se ne accorga: non è mettendo a tacere il nostro dissenso che la società patriarcale ha agito la sua oppressione su di noi?
Pianificare strategie e spazi per la cura di sé all’interno delle nostre organizzazioni è la prima forma di rivoluzione che dobbiamo mettere in atto, per poter essere coerenti con la nostra scelta di attivismo. E per pianificare, occorre prima di tutto ascoltare attivamente, senza giudizio, senza retropensieri, ricordando le parole di Gloria Steinem
“la comprensione reciproca scaturisce dallo stare insieme in una stanza”.
Possiamo essere creative su ciò che possiamo fare in questi spazi, ma prima di tutto dovremmo iniziare a condividere i nostri sentimenti individuali. Dovremmo parlare di cosa intendiamo quando parliamo di uno spazio per la cura di sé.
Facciamo attenzione, non c’è una risposta giusta, ma ci sono diverse idee per creare il perfetto spazio inclusivo.
Magari ascoltando bisogni e sentimenti altrui, potremmo essere più creative, potremmo essere ispirate. Forse, ascoltare l’esperienza di burn out delle altre ed il modo in cui ne sono uscite può aiutarci a parlare del nostro burn out. Forse, se facciamo attenzione a non usare l’espressione “Dovresti fare questa cosa in questo modo….” o peggio “fai così!” quando un’altra donna parla della sua esperienza, possiamo metterci tutte in condizione di condividere i nostri pensieri. Potremmo addirittura spingerci a non silenziare chi esprime una critica squalificandola come “polemica”. Proviamo a partire dal disagio che proviamo quando qualcuno ci dice che stiamo ragionando in maniera errata e mettiamoci in ascolto. Parlo di “noi” e non di “voi” perché ogni giorno cerco di compiere lo sforzo di costruire conversazioni costruttive e non opprimenti, come punto di partenza per prendermi cura di me stessa e delle persone che mi circondano. E le conversazioni costruttive non sono quelle in cui si esprimono unicamente sentimenti di pace e bene mentre si spargono petali di rosa e si sparge profumo di lavanda, coerentemente con quell’idea di delicatezza e leggiadria che tanto piace all’ordine patriarcale. Le conversazioni costruttive sono quelle in cui anche la rabbia trova il suo dignitoso posto a sedere senza dover per forza accavallare le gambe.